“Ogni riferimento a fatti o persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale”. Si legge spesso in esergo o in chiusura ad un’opera di finzione, che però – sempre più spesso – si dimostra un grimaldello per scoprire aspetti nascosti di una realtà a cui spesso mancano le parole più precise – o solo quelle più forti – per essere raccontate. Lo sa bene Lucio Luca, cronista da tre decenni tra le firme di Repubblica, che ben conosce, ben al di là degli escamotage narrativi, l’importanza della presunzione di innocenza fino all’ultimo dei gradi di giudizio, e al contempo – soprattutto – l’essenzialità di attenersi alla legge e, prima ancora, all’etica. Lo si avverte con nitidezza, nell’intenzione stessa di aver voluto raccontare una vicenda che a buon diritto va sotto il titolo, evocativo e forse un po’ abusato, di La notte dell’antimafia. Ma che, con ancora maggior decisione, avrebbe tranquillamente potuto averne uno rubato a Pino Maniaci, “la mafia dell’antimafia”.
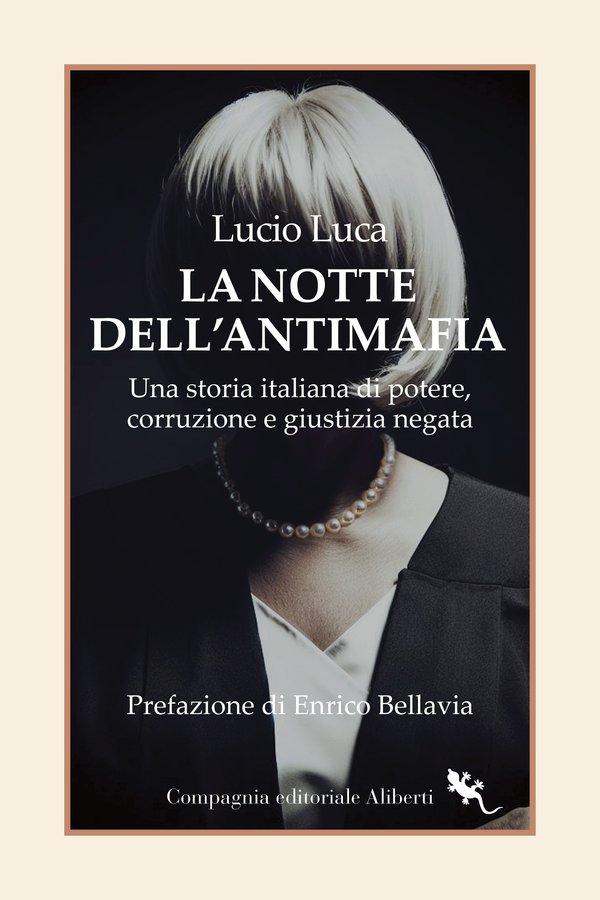
Ci è voluto coraggio – e l’autore lo ammette nemmeno troppo fra le righe, dandone il merito all’editore Aliberti – a dare spazio a una vicenda che qualcuno potrebbe accusare di quello che in altri tempi si sarebbe chiamato “disfattismo”, o si sarebbe usato per depotenziare l’importanza di decenni di lavoro banalizzando pensieri complessi e articolati, come ben ha sperimentato Pier Paolo Pasolini e i suoi esegeti quasi ogni volta che si parla di “fascismo degli antifascisti”. L’antifrasi di Luca, tuttavia, non è soltanto un’espressione di complessità, ma un esercizio di responsabilità etica e civile, oltre che di rigore professionale. Quale altro compito compete al giornalista se non di mostrare il non visto, raccontare quel che non si racconta, essere la voce di chi si è stancato di lamentare un’ingiustizia che, chi dovrebbe garantirne l’assenza, finisce (preferisce) spesso col non vedere. Mantenendosi, però, nei binari della deontologia e del dovere professionale. Per questo, il simbolo del tradimento allo Stato di cui racconta il cronista ragusano perde il cognome, per diventare semplicemente, Silvana, giudice dell’Ufficio Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo, ovvero l’organo deputato a sequestrare ai mafiosi (ma anche ai presunti tali, a fiancheggiatori e prestanome) le loro proprietà, nella consapevolezza che – come già insegnava il giudice Falcone, soltanto agire su denaro e patrimoni può avere un autentico esito a lungo termine per sconfiggere le mafie.
È proprio dietro l’ombra rassicurante degli eroi della lotta alla mafia che la giudice Silvana, (con la consueta ricerca dell’effetto retorico tipica di taluni titolisti, diventata “la zarina” nel corso del successivo procedimento giudiziario oggi passato in giudicato) nascondeva l’abitudine a distribuire regali e favori, usare e abusare dei propri privilegi, godere in molti modi del prestigio derivato dall’aver iniziato il proprio uditorato proprio accanto ai magistrati come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rocco Chinnici. Aveva inferto colpi molto violenti a tutti i nomi più noti e temuti della mafia siciliana, la giudice Silvana, che qui come nel romanzo di Luca si cita soltanto per nome, e di cui tuttavia è ormai facile trovare su tutte le testate le altre generalità, così come per tutto quello che sarà poi chiamato ‘cerchio magico’. Ad esempio, il nome di Tanino, uomo di fiducia della oggi ex giudice, “trovatosi” per questo a gestire, nella sua qualità di amministratore fiduciario, nello stesso momento più di novanta beni e proprietà sottratte a mafiose o presunti tali. Che cosa questo comporti lo sa bene Gianfranco Lena, che con una efficace scelta retorica e simbolica al contempo è l’unico, nel romanzo, a venir onorato di un cognome, il proprio, che più di ogni altra cosa gli preme di non infangare. Non solo perché è quello di suo padre, celebre (e spericolato) imprenditore che ha fatto fortuna col vino e con il lavoro; ma soprattutto perché non è disposto ad accettare che si trovi improvvisamente infangato dall’accusa di collusione, e poi di aperta collaborazione, al punto da esserne stato addirittura socio, di tremendi esponenti del clan dei Corleonesi.


Come Salvatore “Totuccio” Lo Piccolo, che fino al suo arresto nel 2007, era stato considerato il “nuovo capo” di Cosa Nostra. Con questo genere di personaggi l’imprenditore Francesco Lena era accusato di fare affari, salvo poi scoprire che il Lo Piccolo che risultava nelle carte che attestavano un rapporto di lavoro tra i due doveva avere almeno vent’anni di più. E non solo: la parola di due pentiti, che sostenevano di aver sentito nominare il Lena in un paio di incontri riservati, era stata sufficiente a farlo accusare di aver venduto un appartamento (che in realtà sarebbe entrato in suo possesso due decenni più tardi, persino allo stesso Riina. Ma perché tutto questo? Nella ricostruzione della vicenda di cui fa romanzo Lucio Luca, ospite domenica 22 settembre a Pordenonelegge, non per un “semplice” errore giudiziario. Sarebbe piuttosto, suggerisce la finzione narrativa, l’esito di un sistema, lo stesso che induceva Silvana ad usare gli agenti della scorta per fare la spesa o passare a ritirare i vestiti in tintoria, i professori dell’università del figlio a procurargli una laurea di cui ignorava persino gli argomenti, e le amiche che per lo Stato ricoprivano la carica di prefetto di Palermo a fare del marito, ingegnere con poco lavoro, un esperto di ogni argomento, buono per qualsiasi consiglio di amministrazione.
Il lavoro del giornalista siciliano ha la lucidità di non far sconti a nessuno, nemmeno a chi dice la verità, come Maniaci, a sua volta inascoltato. Ma, soprattutto, di riconoscere le radici di un problema di cui, con la stessa amarezza di Gianfranco Lena, anche all’indomani delle condanne per elargizioni, i favori, la concussione dispensata a piene mani nella convinzione di essere intoccabile, rimane da chiedersi se possa davvero essere considerata l’esito del buio dell’avidità di una singola persona o di un piccolo gruppo e non, piuttosto, il sintomo di un sistema. Che sfrutta a proprio vantaggio i vuoti di una legge importante come quella nota con il nome del sindacalista Pio La Torre. Il cosiddetto “doppio binario”: anche in presenza di un’assoluzione penale dalle accuse per associazione mafiosa, i beni e le proprietà degli accusati (in gergo, dei proposti) vengono tolti dalla loro disponibilità nel momento stesso dell’accusa. Non è più sui rappresentanti della legge che ricade l’onere della dimostrazione di colpevolezza, ma all’accusato è demandato il compito di difendersi. Nel frattempo, il bene sequestrato passa nelle mani di un amministratore nominato dall’ufficio del tribunale per le misure di prevenzione. È solo in caso di condanna, quasi sempre molto differita nel tempo, che interviene la confisca vera e propria. In questo lasso di tempo, spesso (volutamente, per via delle lentezze della burocrazia, molto dilatato nel tempo, la stragrande maggioranza delle aziende sequestrate falliscono, e chi vi lavorava perde la propria fonte di sopravvivenza.
Uno stato di cose tanto noto e riconosciuto a tutte le latitudini da indurre il procuratore generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni, parlando della ‘ndrangheta, su cui si agisce alla stessa maniera, «Non possiamo fare passare l’idea che la ‘ndrangheta crei lavoro e noi, istituzioni, lo distruggiamo». Non resta che raccontare, la verità, con l’esattezza e l’eleganza della narrazione di cui il romanzo di Lucio Luca offre una efficace dimostrazione, per essere certi che, attraverso la consapevolezza dell’opinione pubblica, nessun magistrato possa macchiare la propria toga e la memoria di chi vi ha speso la vita intera, piegando ai propri personali appetiti la lotta quotidiana dell’antimafia.



